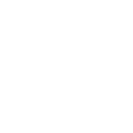Parlare di moda non sempre è parlare di leggerezza ma alcune assonanze non sono forzate, soprattutto se si parla di “fast fashion”. C’è la bella leggerezza del sentirsi bene nel proprio nuovo abititino e c’è la leggerezza di forzare un consumo di risorse sempre meno opportuno. La moda per esistere e soprattutto resistere sul mercato, deve necessariamente uccidere se stessa, le proprie proposte, modelli e colori ad ogni stagione. E questo vale sia per i brand blasonati sia per i brand low cost, presenti in franchising e sul web in infinite catene da nord a sud da est ad ovest del nostro sempre più fragile ma interconnesso globo terracqueo.
Ma una linea di demarcazione importante tra le aziende c’è: capi fatti per durare nel tempo, classici intramontabili che per qualità, rigore di stile e ricerca di materiali poco impattanti ambientalmente possono resistere per anni nei nostri armadi e capi “fast fashion” di scarsa se non scarsissima qualità fatti per durare a qualche lavaggio, tutt’al più una stagione.
Sono questi ultimi, prodotti in esubero per essere disponibili contemporaneamente ed in abbondanza in ogni mercato, ad alimentare un universo di rifiuti che da almeno quindici anni invade il deserto di Atacama in Cile.
I report dello scorso anno parlano di almeno 59.000 tonnellate provenienti da Stati Uniti, Europa ed Asia in arrivo annualmente al porto di Iquique, zona franca di Alto Hospicio nel nord del Cile. Una parte di questi vestiti - nuovi eppure già vecchi per i nuovi trend della moda - circa un terzo, ritorna sui mercati dell’America Latina, il rimanente, cioè circa 40.000 tonnellate, finisce nelle discariche abusive nel deserto di Atacama. Un vero e proprio “nascondiglio a cielo aperto” per un Cile che formalmente non accetta stoffe nelle discariche autorizzate. Un nascondiglio conosciuto
dall’universo mondo e che si stima ospiti almeno 500 mila tonnellate di rifiuti tessili che di tanto in tanto letteralmente si accendono, non per i riflettori degli ambientalisti preoccupati, ma per gli incendi. Dolosi. E in aria si sprigionano sostanze tossiche deleterie.
Una follia che la leggerezza del mercato globale non cessa di foraggiare e che i provvedimenti politici non sanno arginare. Un cimitero immenso di milioni di abiti mai acquistati, mai indossati. Realizzati a costi irrisori da una forza lavoro sottopagata e non tutelata. Prodotti che hanno richiesto una quantità di materie prime da capogiro per essere creati e per creare i loro necessari accessori (bottoni, cerniere, fibbie, cinture). E ancora uso di tonnellate su tonnellate di composti chimici per le colorazioni, per i trattamenti di fissaggio e quant’altro. Senza considerare gli sprechi collaterali, quelli per gli imballaggi e per i trasporti.
E se nel deserto di Atacama si accumulano le produzioni in eccesso di poca e scarsa qualità realizzate da brand low cost, in Ghana, al mercato di Kantamanto, uno dei maggiori hub per abiti usati nel centro di Accra, secondo la Rivista Africa arrivano ogni settimana 15 milioni di vestiti usati. Arrivano da Europa, America, Canada, Asia. Solo il 60% è riutilizzabile dopo lavaggi e trattamenti, il resto - 6 milioni di abiti la settimana - si brucia nelle baraccopoli o si abbandona in discariche abusive o si getta direttamente nelle acque del Golfo di Guinea. Con danni incalcolabili alla salute e all’ambiente. Pure Oxfam - la più che accreditata confederazione internazionale di organizzazioni non profit fondata nel Regno Unito nel 1942 che tutt’ora si batte per la riduzione della povertà globale attraverso aiuti umanitari e progetti di sviluppo - stima che il 70% degli indumenti usati del mondo giunge in Africa.
Due casi apicali quello cileno del deserto di Acatama e quello di Accra in Ghana, ma certamente non unici.
Le virtuose direttive dell’Unione Europea atte a incentivare innanzitutto il riuso e poi il riciclo dei prodotti tessili paiono ancora una voce flebile. Oltre alla responsabilità dei produttori estesa in ogni fase del processo produttivo del tessile per arginare sprechi e forme di inquinamento ambientale compreso il fine vita delle loro merci, si dovrebbe affrontare un grande, immenso lavoro di divulgazione perché la conoscenza che i consumatori hanno circa l’impatto che ogni singolo indumento prodotto ha sull’ambiente è ancora troppo scarsa. L’abitudine promossa dalla fast fashion inebria ma dovrebbe sgomentare.
Una educazione civica e capillare al consumo responsabile certamente può, con più forza di qualsiasi norma, dettare nuovi paradigmi al mercato globale.